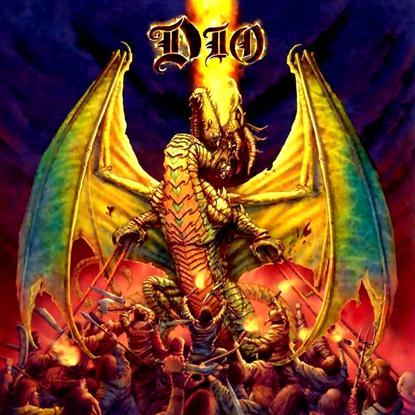Mi son sempre chiesto come è possibile continuare ad adorare in maniera sperticata i Watain, pur sapendo che sono almeno 12 anni che non tirano fuori un disco killer. Le spiegazioni sono molteplici e, per quanto ne so, sono totalmente supposizioni mie: ma l’idea è che dopo il clamore suscitato con Lawless Darkness del 2010, la band svedese è forse rimasta soffocata dal proprio hype o dalla voglia di scappare da sé stessi. Ecco che si potrebbe spiegare così perché i Watain hanno incominciato a perdere il proprio trademark a partire dalle sortite dark di The Wild Hunt del 2013 e non hanno di certo fatto meglio con Trident Wolf Eclipse, disco che era brutto in sé, anzi aveva alcuni brani intensi, ma era un lavoro che “normale”, o poco sincero, e per questo non posso riconoscerne una reale grandezza.
The Agony & Ecstasy of Watain è, in maniera quantomeno paradossale visto che ormai avevo quasi abbandonato ogni speranza, il disco che mi ha fatto ricredere su quanto stanno facendo i Danielsson e soci. Un LP che suona compatto, con tante tracce forti, e che non cerca a) di sperimentare per poi ripudiare il proprio stesso percorso e b) di sembrare un disco veloce, furente, come mero strumento di “redenzione” dal mezzo passo falso. Nel 2022 i Watain devono essere arrivati alla conclusione che l’unico modo per essere sé stessi, per quanto siano a mio parere sempre e comunque debitori di certe sonorità, è essere sé stessi.
Essere sé stessi è quindi non rifugiarsi dietro comodità accertate (le velocità del 2018 sono parte del DNA, ma non un posto dove nascondersi), ma abbracciare tutto lo spettro delle sonorità che, ad oggi, li contraddistingue. The Agony & Ecstasy of Watain parte in maniera forse deboluccia, Ecstasies in Night Infinite non riesco mai a ricordarmela, ma la maturità sta nel riprendersi con il passare del tempo e incominciare la risalita proprio dalla successiva The howling: non perfetta, ma ha un piglio più convincente di chi la precede. Nel 2022 i brani più lenti, la quantomeno passabile traccia strumentale (che, a seconda delle giornate, reputo inutile o necessario stacco) e poi i classici assalti con a baionetta sguainata e bombe a mano si fondono in maniera completa, senza che mi assalga la sensazione di totale inutilità o caos.
E qua vorrei aprire un discorso diverso: le melodie e le atmosfere. Queste sono perfettamente evidenti nel 2022, tanto che finalmente dentro un LP della band svedese si respira quella sensazione di oscurità e dannazione nonché, come amano scrivere quelli che di musica se ne intendono, si percepiscono forti e chiare le atmosfere luciferine. Vi riassumo il concetto con una canzone: Serimosa. Ad un primo ascolto l’avevo cassata, ma poi, ascoltata in maniera decente e non come sottofondo mentre faccio altro, ha dispiegato tutto il proprio potenziale. Credetemi, non c’è bisogno (sempre e solo) di canzoni che vanno a mille all’ora per richiamare Satana su questo cazzo di pianeta. E così potrei dire anche per We Remain, per quanto quella sensazione di pezzo alla Dimmu Borgir non mi abbandoni neanche ora (non chiedetemi perché).
The Agony & Ecstasy of Watain è il disco che riporta i Watain nell’alveo che più gli è congeniale. Con buona probabilità non riusciranno più a raggiungere la qualità pre-2010 (Lawless Darkness), ma nel 2022 almeno hanno riportato la barra a dritta con un LP compatto. Non sarà sempre ispiratissimo, ma i quasi 50 minuti di questo disco mi hanno più di una volta fatto fare headbanging e tirato via un po’ del peso della quotidianità.
[Zeus]